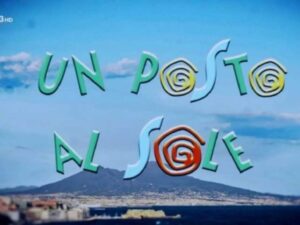Mio zio la cucinava con un rito tutto suo e nel quartiere non si parlava d’altro. La genovese napoletana non è solo un sugo, è un enigma di famiglia

Il profumo cominciava a salire già dal pianerottolo. Quello delle cipolle che cuociono piano, col tempo che sembra allungarsi insieme al sugo. Un odore dolce, quasi caramellato, che si infilava sotto le porte e si arrampicava nelle scale, come per dire: “Scendete, qui si mangia sul serio”.
Non era domenica se non c’era una pentola che borbottava da ore. Non era Napoli, forse, senza quel rito lento e un po’ teatrale che comincia all’alba e finisce quando il cucchiaio si rifiuta di staccarsi dal piatto. La genovese, sì. Ma non quella di Genova, perché da quelle parti nessuno ne ha mai sentito parlare.
A Napoli invece è una specie di patrimonio non scritto, tramandato come una formula magica, con dosi approssimative e gesti che si fanno “a occhio”, “a sentimento”.
La storia è piena di buchi, come tutte le leggende vere. C’è chi dice che la chiamassero così per colpa di alcuni osti genovesi arrivati nel porto, chi invece parla di una lontana influenza francese, roba da alta cucina del Settecento. Ma la verità è che nessuno ha mai trovato una genovese a Genova.
A Napoli invece sì, ovunque. E ognuno la fa a modo suo, anche se la base non cambia: cipolle a vagonate, un pezzo di carne intero (girello o lacerto, scegliete voi), sedano e carota se proprio si vuole strafare, ma con moderazione. E soprattutto, niente pomodoro. Niente fretta. Niente domande inutili.
Perché il bello della genovese è che si fa da sola, a patto di avere il tempo di guardarla diventare sugo. Si comincia con una montagna di cipolle dorate tagliate sottili, si mette la carne a rosolare piano piano, e poi si lascia che tutto si sciolga, che il colore cambi, che il profumo diventi una promessa.
Lo zio che sapeva il fatto suo: così preparava la genovese
Nel mio quartiere, però, c’era uno che questa promessa la manteneva meglio di tutti. Mio zio Gennaro. Un uomo d’altri tempi, con la radio sempre accesa su Radio Marte e una sigaretta mai accesa all’angolo della bocca.

Tutti sapevano che la sua genovese era speciale. E non per modo di dire. Si faceva la fila fuori casa sua, la domenica. C’erano quelli che passavano “per un saluto” e finivano a tavola, quelli che portavano le vaschette di alluminio, quelli che si offrivano di dare una mano solo per mettere il naso nella pentola.
Ma il mistero più grande era quell’ingrediente segreto. Lui lo diceva con naturalezza, come fosse la cosa più ovvia del mondo. “Ci metto una cosa che non ci mette nessuno”, ripeteva. Ma non ha mai detto cosa. E noi, poveri nipoti, siamo cresciuti con il dubbio. Era una spezia? Una punta d’aceto? Una foglia misteriosa buttata dentro all’ultimo? Niente. Nessuno lo sa, nessuno l’ha mai saputo.
Dopo che se n’è andato, abbiamo cercato ovunque. Nelle ricette scritte a mano, nei taccuini con le date delle giocate al lotto, perfino tra le bollette. Ma nulla. Eppure, ogni tanto, quando provo a rifarla, mi sembra che un pezzetto di quel sapore ci sia ancora.
Forse perché certe cose non si insegnano: si assorbono stando lì, a guardare, a sentire, a rubare con gli occhi. O forse perché l’ingrediente segreto era proprio lui, con la sua voce roca e il suo modo di girare il cucchiaio come se stesse accordando uno strumento.
La genovese, alla fine, è questo: un sugo che cuoce il tempo, e lo rende buono da mangiare.